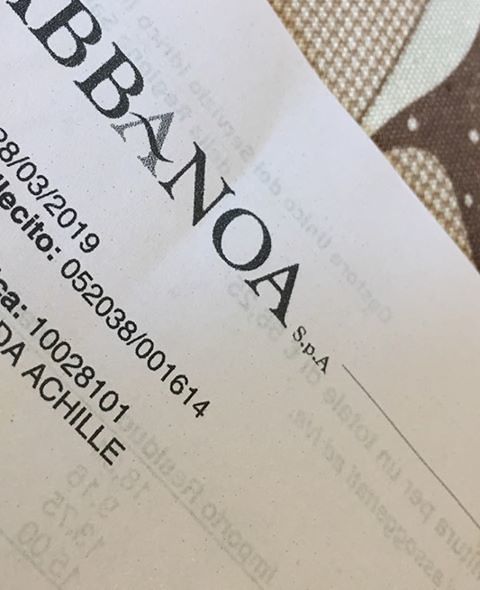Di Giulio Neri
All’inizio è il rifiuto al cospetto di donne che rimandano a una cultura di matriarcati più o meno espliciti. Elaborare i temi dell’identità, dell’appartenenza a una Terra e a una famiglia, passa anche per la rivolta. È la sana follia della giovanissima Melania, protagonista di “Le Furie”: serve un colpo di testa per lasciare i propri luoghi e la propria gente, per sfuggire a ruoli già assegnati.
C’è la nonna, Altea, baluardo della tradizione, vedova corazzata e mai un sorriso; e c’è la mamma, Tiziana, prima vittima di questo dramma femminile, medico del paese (come il padre) e abbandonata dal marito. Ogni domenica, i pranzi a tre sono un gineceo di freddezza, rimproveri e angherie pedagogiche; a una bambina irrequieta si insegna con parole scarne e, anzitutto, con l’esempio. Altea, in tal senso, è simbolo di rigidità fino all’autolesionismo; ma – non di meno – è un monumento che schiaccia figlia e nipote. Se la prima non è mai riuscita a ribellarsi, la seconda troverà nella frustrazione e nell’infelicità della madre il coraggio per staccarsi, partire e studiare fuori sede (Beni Culturali e non Medicina, come in famiglia davano per scontato).
Ci si stacca, ma il legame non si può recidere. È da questi controversi sentimenti tra donne che si innesca un processo di identità plurali: Melania come figlia, come sarda, come donna; e come madre. Tra rivendicazioni individuali e affrancamento che ripudia i modelli erotico-culturali dominanti (con riferimento ai tronisti e all’appiattimento conformistico delle più giovani).
La contrapposizione scaturita nel paese d’origine si trascina anche nella grande città dove la protagonista porta avanti gli esami universitari e lavora in un museo: alla propria storia non si scampa; perché nella Storia, a saperlo leggere, c’è già un destino. I ricordi, talvolta, prendono il sopravvento, e una nostalgia ineffabile opera incessantemente sui conflitti irrisolti. Nei tempi dilatati della lontananza si continua a non capire. Ma a un livello più alto di sovrintelligenza affettiva (oltre la lingua, oltre gli schemi psicologici) si perdona e si accetta; tanto la nonna dispotica quanto la madre imperturbabile.
Lo studio della fotografia, argomento della tesi di laurea, diventa in Melania strumento per approfondire i volti, gli sguardi e l’amore che le donne di casa hanno vissuto o mancato; e segna il passaggio a una cultura che interiorizza e vivifica il Passato senza più giudicarlo. L’animo femminino è una stratificazione complessa di passioni e tentativi di razionalizzazione: il Sé ritrova ogni volta un pezzo nuovo, riflesso dopo riflesso. Stare al mondo non significa comprendere e incasellare, ma riconoscersi anche per il tramite di chi ci ha preceduto, e ascoltarsi per andare avanti senza dimenticare da dove si è partiti.